|
Il
cinema per l'arte.
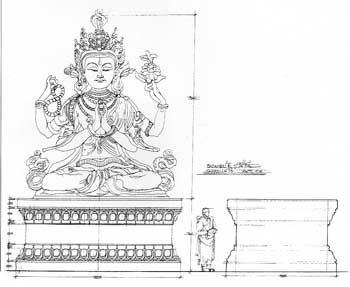 C'è
un posto in Marocco, Ouarzazate, alle porte del Sahara, dove nel 1996
negli "Studio Atlas", uno dei luoghi sacri del cinema
marocchino, si sono costruite e girate tutte le scene del film Kundun
di Martin Scorsese. Io firmavo scenografia e costumi. C'è
un posto in Marocco, Ouarzazate, alle porte del Sahara, dove nel 1996
negli "Studio Atlas", uno dei luoghi sacri del cinema
marocchino, si sono costruite e girate tutte le scene del film Kundun
di Martin Scorsese. Io firmavo scenografia e costumi.
Poiché
il film racconta la vita
del Dalai Lama in Tibet, la scenografia doveva ricreare l'atmosfera
tibetana. Per questo, per giorni e giorni, mi sono dedicato insieme ai
miei collaboratori alla realizzazione di un grande Buddha d'oro, perché
d'oro era la Sala del Potala.
Era
curioso vedere come il Tibet si mescolasse agli elementi della cultura
berbera, al punto di non capire cosa appartenesse a chi: le culture
essenziali si avvicinano più velocemente alla verità del vivere
quotidiano.
Il
film fu distribuito nel mondo, ma le scene restarono a Ouarzazate. E il
Buddha con loro, fino al giorno in cui arrivò la richiesta di prestarlo
alla città di Milano che si preparava ad accogliere ufficialmente il
Dalai Lama.
Sapere
che quel Buddha avrebbe potuto continuare a vivere anche altrove è
stato per noi fonte di gran soddisfazione. Come soddisfacente è sapere
che il cinema, con le sue produzioni, può contribuire a valorizzare un
percorso culturale grazie alla sua capacità di dare corpo alle visioni.
Un augurio sincero perché a questo seguano altri viaggi da e per
l'universo tibetano.
Dante
Ferretti
Destinazione
Buddha.
MILANO.
Quando i tecnici hanno cominciato a smontarlo e a preparare le casse per
portarselo via dal Marocco, un nugolo di berberi è comparso a dorso di
cammello attorno agli studios cinematografici di Ouarzazate. Gridavano:
«Ciao Buddha, torna presto». E hanno continuato a gridare mentre
giravano, sempre a dorso di cammello, attorno alla statua di legno
dorata del buddha Cenresig, realizzata per il film di Martin Scorsese
Kundun nella Cinecittà marocchina in mezzo al Sahara. Sono musulmani di
mente aperta in questo deserto che, per ragioni politiche (in Tibet il
set è stato proibito) e scenografiche, ha visto sorgere dal nulla un
tempio tibetano e ha ospitato come gente di casa 575 attori e comparse
con gli occhi a mandorla provenienti dalle pendici dell'Himalaya.
Quando
i monaci dai lunghi abiti viola e le teste rasate, durante le pause
delle riprese, recitavano i loro mantra, i locali li circondavano
rispettosamente, contagiati da quella scenografica ritualità fatta di
suoni cupi e movimenti aggraziati. E fin dall'inizio furono attratti
dalla grande statua che troneggiava sul set: « È l'immagine di
Cenresig» gli spiegavano «il Dio della Compassione che per noi
tibetani si è incarnato nel Dalai Lama ».
Non
sapevano, i berberi di Ouarzazate, che altri musulmani ben meno
tolleranti distrussero duemila anni fa, in India, migliaia di templi e
statue, comprese quelle di Cenresig, conosciuto là col suo nome
sanscrito di Avalokitesvara. Anche a Ouarzazate il Buddha della
compassione è finito a pezzi, sezionato però stavolta da mani esperte,
disaggregato come in un rituale tantrico, imballato in grandi container
e trasportato, a spese di una compagnia di armatori italiani, fino a
Genova. Destinazione finale Milano, dove ricomparirà tra qualche
giorno, rimontato e restaurato dagli stessi esperti di maquillage
cinematografico assoldati dallo scenografo Dante Ferretti e da Scorsese,
al centro della Rotonda
della Besana. L'ex Lazzaretto dell'Ospedale Maggiore, dove furono
ambientate alcune tra le pagine più suggestive dei Promessi
Sposi, è stato, infatti, trasformato in un "gömpa"
tibetano, un tempio ottagonale incastonato nell'antica struttura a forma
di croce greca le cui quattro braccia ospiteranno una grande mostra sul
Tibet al cui centro un altro ottagono, simbolo dell'Ottuplice sentiero
di salvezza indicato dal Buddha, realizzato da Michelangelo Pistoletto,
diventerà il nuovo trono di Cenresig.
 A
inaugurare il 20 ottobre la mostra è un ospite d'eccezione: il Dalai
Lama stesso, l'uomo che di Cenresig è il volto umano, e che della
compassione ha fatto nella realtà la bandiera della sua vita tanto da
conquistarsi il premio Nobel per la pace. Gli organizzatori della mostra
hanno giocato sulla sua
doppia immagine di uomo e di divinità per allestire attorno alla statua
che lo rappresenta un gioco «di richiami tra la terra e il cielo»,
come li definisce l'ideatrice Sonia Deotto. Ecco alla base di Cenresig
il bianco del loto, fiore delle paludi fangose, che simboleggia la
purezza della natura divina inattaccabile dalle contaminazioni mondane.
Ed ecco i colori degli elementi corrispondenti ad altre entità
sovramondane e alle direzioni cardinali: l’azzurro dello spazio, il
rosso del fuoco, il giallo della terra. Colori che nell'opera di
Pistoletto rappresentano gli stati di calma e movimento caratteristici
della natura della mente umana, quieta nella sua essenza, perennemente
in moto attraverso i pensieri. Il visitatore
è accolto nel piccolo cosmo di Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama e della
sua gente, attraverso una serie di oggetti d'arte, pitture (thang-ka)
dal XII al XX secolo, oggetti d'uso, rituali e strumenti musicali, una
tenda nomade da cerimonia, un mandala di sabbia colorata preparato
granello per granello durante l'esposizione. Per festeggiare i dieci
anni del Nobel per la pace ci saranno anche altrettanti ritratti inediti
del Dalai di Henry Cartier-Bresson e di sua moglie Martine Frank, oltre
alle immagini realizzate in
Tibet da Fosco Maraini negli Anni 30 e 40. A
inaugurare il 20 ottobre la mostra è un ospite d'eccezione: il Dalai
Lama stesso, l'uomo che di Cenresig è il volto umano, e che della
compassione ha fatto nella realtà la bandiera della sua vita tanto da
conquistarsi il premio Nobel per la pace. Gli organizzatori della mostra
hanno giocato sulla sua
doppia immagine di uomo e di divinità per allestire attorno alla statua
che lo rappresenta un gioco «di richiami tra la terra e il cielo»,
come li definisce l'ideatrice Sonia Deotto. Ecco alla base di Cenresig
il bianco del loto, fiore delle paludi fangose, che simboleggia la
purezza della natura divina inattaccabile dalle contaminazioni mondane.
Ed ecco i colori degli elementi corrispondenti ad altre entità
sovramondane e alle direzioni cardinali: l’azzurro dello spazio, il
rosso del fuoco, il giallo della terra. Colori che nell'opera di
Pistoletto rappresentano gli stati di calma e movimento caratteristici
della natura della mente umana, quieta nella sua essenza, perennemente
in moto attraverso i pensieri. Il visitatore
è accolto nel piccolo cosmo di Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama e della
sua gente, attraverso una serie di oggetti d'arte, pitture (thang-ka)
dal XII al XX secolo, oggetti d'uso, rituali e strumenti musicali, una
tenda nomade da cerimonia, un mandala di sabbia colorata preparato
granello per granello durante l'esposizione. Per festeggiare i dieci
anni del Nobel per la pace ci saranno anche altrettanti ritratti inediti
del Dalai di Henry Cartier-Bresson e di sua moglie Martine Frank, oltre
alle immagini realizzate in
Tibet da Fosco Maraini negli Anni 30 e 40.
A
rendere omaggio al Dalai Lama
ci saranno praticamente tutte le autorità locali e nazionali-Comune
e Provincia di Milano, Regione Lombardia, ministero della Cultura-che
hanno creato attorno al suo arrivo un evento degno della recente
accoglienza a New York dove, al Madison Square Garden e al Central Park,
più di 200 mila persone erano accorse ad ascoltare i suoi insegnamenti
spirituali. Anche a Milano, del resto, Cenresig-Dalai offrirà i suoi
consigli per la salute della mente umana in uno spazio come il Palalido,
che non sarà il Madison, ma che dispone pur sempre di alcune migliaia
di posti già in gran parte prenotati, comprese
le "sedie" da mezzo milione
vicine al trono del grande Lama destinate a discepoli ricchi che
vorranno provare l'emozione di stare vicino all’involucro umano"
assunto in questa fine Millennio dal pio della Compassione per
proteggere ciò che resta della religione del Tetto del mondo.
Raimondo
Bultrini
Da
"Il Venerdì di Repubblica" n° 604 del 15 ottobre 1999
|